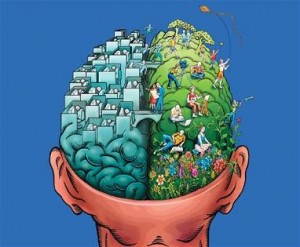“Più vai lento, più vai veloce.”
Richard Kluft
L’EMDR è un metodo terapeutico evidence based che aiuta le persone che hanno vissuto una o più situazioni traumatiche ad elaborare i ricordi e a “liberare” la mente dai frammenti più dolorosi e irrisolti, che spesso sono alla base dei principali sintomi da stress post traumatico, d’ansia e depressivi.
E’ stato riconosciuto come metodo d’elezione per il trattamento del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e sono numerose ormai le evidenze scientifiche sulla sua efficacia nel trattamento di sindromi complesse correlate a traumatizzazione cronica e disturbi dissociativi (trovate qui informazioni e riferimenti ufficiali). La rapidità con cui permette di elaborare eventi traumatici del passato e acquisire una nuova prospettiva su di essi è una delle principali e più sorprendenti caratteristiche, a confronto con altri tipi di terapie che lavorano sulle memorie traumatiche, e questo ha alimentato grande interesse da parte dei clinici e dei pazienti stessi.
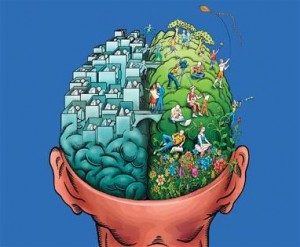 Di particolare interesse sono le recenti pubblicazioni scientifiche portate avanti da un team di ricerca tutto italiano (Pagani M., et al 2010, 2011) sul monitoraggio dell’attività cerebrale tramite elettroencefalogramma (EEG) prima, durante e dopo un trattamento EMDR: i risultati hanno evidenziato un cambiamento sorprendentemente significativo tra le prime sedute e le ultime. In particolare nelle prime il recupero dei ricordi autobiografici, delle immagini e delle emozioni negative associate attiva intensamente la corteccia limbica e la corteccia prefrontale (responsabili delle risposte emotive e delle nostre reazioni in situazioni di emergenza o di pericolo) e questa risposta permane durante l’intero processo di desensibilizzazione; mentre l’attività corticale si modifica radicalmente a conclusione del processo di elaborazione, mostrando una maggiore attivazione delle regioni corticali temporali, parietali e occipitali con una chiara lateralizzazione sinistra. Questi dati hanno permesso di ipotizzare l’effettivo “passaggio” del ricordo traumatico da una rete mnestica sottocorticale, che continua a riattivare nel PTSD il ricordo traumatico a causa della reattività delle aree del cervello limbico e prefrontali legate alla percezione del pericolo e alle risposte di emergenza, ad una rete più corticale in cui il ricordo viene riorganizzato in una memoria più cognitiva e semantica, che permette la rievocazione dell’evento traumatico, ma non più delle reazioni emotive dolorose ad esso associate. “Queste scoperte suggeriscono un‘elaborazione cognitiva dell’evento traumatico in seguito a terapia EMDR riuscita e sostiene l’evidenza di distinti modelli neurobiologici di attivazione del cervello durante i movimenti oculari bilaterali nella fase di desensibilizzazione dell’EMDR (fonte EMDRItalia.it).”
Di particolare interesse sono le recenti pubblicazioni scientifiche portate avanti da un team di ricerca tutto italiano (Pagani M., et al 2010, 2011) sul monitoraggio dell’attività cerebrale tramite elettroencefalogramma (EEG) prima, durante e dopo un trattamento EMDR: i risultati hanno evidenziato un cambiamento sorprendentemente significativo tra le prime sedute e le ultime. In particolare nelle prime il recupero dei ricordi autobiografici, delle immagini e delle emozioni negative associate attiva intensamente la corteccia limbica e la corteccia prefrontale (responsabili delle risposte emotive e delle nostre reazioni in situazioni di emergenza o di pericolo) e questa risposta permane durante l’intero processo di desensibilizzazione; mentre l’attività corticale si modifica radicalmente a conclusione del processo di elaborazione, mostrando una maggiore attivazione delle regioni corticali temporali, parietali e occipitali con una chiara lateralizzazione sinistra. Questi dati hanno permesso di ipotizzare l’effettivo “passaggio” del ricordo traumatico da una rete mnestica sottocorticale, che continua a riattivare nel PTSD il ricordo traumatico a causa della reattività delle aree del cervello limbico e prefrontali legate alla percezione del pericolo e alle risposte di emergenza, ad una rete più corticale in cui il ricordo viene riorganizzato in una memoria più cognitiva e semantica, che permette la rievocazione dell’evento traumatico, ma non più delle reazioni emotive dolorose ad esso associate. “Queste scoperte suggeriscono un‘elaborazione cognitiva dell’evento traumatico in seguito a terapia EMDR riuscita e sostiene l’evidenza di distinti modelli neurobiologici di attivazione del cervello durante i movimenti oculari bilaterali nella fase di desensibilizzazione dell’EMDR (fonte EMDRItalia.it).”
La ricerca su questi meccanismi neurobiologici andrà avanti e cidarà sempre più risposte, ma quello che tuttavia resta a noi terapeuti è: come declinare il metodo nella clinica quotidiana?
Come spesso accade i risultati scientifici fanno crescere entusiasmo e speranze tra clinici e pazienti, sviluppando da un lato grande curiosità e passione nella ricerca di evidenze sperimentali, ma da l’altro alimentando una certa quota di “pensiero magico” circa l’efficacia del metodo e la sua applicabilità!
E’ dunque importante sapere per tutti, clinici e pazienti che vorranno avvicinarsi a questo tipo di trattamento, che si tratta di una tecnica terapeutica che va integrata in un percorso di psicoterapia e soprattutto in una relazione terapeutica.
Come tale l’EMDR offre incredibili risultati a fronte però di una cornice di lavoro molto specifica, articolata e solida, in cui sarà importante definire dettagliatamente la diagnosi, la storia di vita, la sintomatologia presente e le risorse presenti nel paziente per fronteggiare la vita quotidiana e le emozioni veementi che spesso vengono stimolate dalla rievocazione del ricordo target su cui si sceglie di lavorare.
Nella mia esperienza le condizioni di miglior efficacia sono:
- La corretta diagnosi e l’approfondimento di disturbi dissociativi sottostanti;
- L’individuazione dei ricordi target effettivamente collegati alla sofferenza attuale del paziente;
- La creazione di un’alleanza terapeutica chiara su obiettivi, metodo e fasi della terapia;
- Una relazione di fiducia, in cui paziente e terapeuta possano affrontare la fase della elaborazione delle memorie traumatiche in un contesto percepito sicuro e privo di pericoli per entrambi;
- La conoscenza e applicazione del protocollo standard come prima scelta e la padronanza di tecniche di integrazione cognitive e corporee da utilizzare nei casi più complessi;
- Offrire sempre al paziente la possibilità di scegliere durante l’intero processo di cura;
- Riconoscere e rispettare le resistenze e le fobie che possono attivarsi verso il recupero delle memorie, anche in presenza di una grande motivazione del paziente al lavoro EMDR;
- Il processo di elaborazione può sollecitare inizialmente emozioni negative, ma non deve essere in nessun caso traumatico; quando il momento è quello giusto le emozioni negative tendono a ridursi abbastanza rapidamente e a lasciare spazio e nuove emozioni e prospettive;
- Seguire un percorso a fasi che preveda una fase di stabilizzazione iniziale del paziente, che consenta una buona padronanza dello “scenario” su cui si andrà a lavorare e dei possibili vantaggi e svantaggi del lavoro stesso, e solo successivamente un lavoro di elaborazione mirato e diretto sulle memorie traumatiche.
Se queste caratteristiche non vengono rispettate, il lavoro EMDR rischia di generare ulteriori resistenze e di aumentare la fobia del ricordo traumatico e il senso di impotenza spesso tipico in persone traumatizzate.
Quando al contrario queste condizioni sono rispettate, l’EMDR permette di “volare” verso una nuova prospettiva, di rinnovare le proprie risorse verso la resilienza necessaria ad andare avanti in una vita piena e caratterizzata dal recupero di un contatto profondo, solido e integrato con se stessi, con gli altri e con la realtà.
Certo è che i tempi per raggiungere questi obiettivi possono variare da persona a persona e certamente si allungano in situazioni più complesse di traumatizzazione cronica, ma in psicoterapia a volte la lentezza produce cambiamenti più grandi e più duraturi.