“E’ difficile credere all’anoressia mentale. Chi la osserva da fuori non riesce a concepire che il cibo possa diventare un nemico all’improvviso. Chi la vive non capisce più come sia possibile per le persone riuscire a mangiare senza pensieri, senza ansia, senza angoscia.”
L’incomprensione, la distanza e l’estraneità tra mondo interno e mondo esterno sembra il filo conduttore del celebre libro di Alessandra Arachi “Briciole”, pubblicato nel 1994 ma che resta ancora un valido riferimento per chi vive o voglia conoscere il mondo interiore di chi soffre di anoressia e bulimia nervosa.
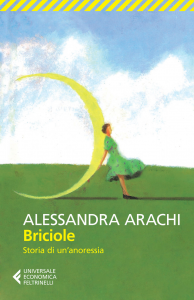 “Briciole” è un testo diretto, spesso duro, che racconta senza giraci attorno i pensieri e le emozioni di chi vive ogni giorno la paura del cibo, del peso e di quello che rappresenta per la propria storia e per la propria identità. L’inizio dell’anoressia raccontata in prima persona dall’autrice è, come spesso accade, in adolescenza: il confronto faticoso con gli altri, il corpo che cambia improvvisamente e non sempre nel modo desiderato, l’osservazione attenta di ciò che i coetanei più apprezzano e poi all’improvviso l’idea che basti dimagrire per non sentirsi più esclusi!
“Briciole” è un testo diretto, spesso duro, che racconta senza giraci attorno i pensieri e le emozioni di chi vive ogni giorno la paura del cibo, del peso e di quello che rappresenta per la propria storia e per la propria identità. L’inizio dell’anoressia raccontata in prima persona dall’autrice è, come spesso accade, in adolescenza: il confronto faticoso con gli altri, il corpo che cambia improvvisamente e non sempre nel modo desiderato, l’osservazione attenta di ciò che i coetanei più apprezzano e poi all’improvviso l’idea che basti dimagrire per non sentirsi più esclusi!
Una semplice dieta. E in pochissimo tempo arrivano una pioggia di complimenti, sguardi complici, ogni giorno scorre più facile ad ogni chilo perso. Perché fermarsi? Così l’ammirazione degli altri diventa un nuovo nutrimento: insufficiente per il corpo, ma molto molto potente per la mente!
“In meno di un mese il cervello è riuscito a trasformare un pezzo di pane in un dannoso concentrato di zuccheri, l’olio in un accumulo irrecuperabile di grassi. Diffidavo di qualsiasi cosa commestibile, ma riservavo al cibo tutti i pensieri della mia giornata.”
Così inizia il calvario della protagonista: aver trovato nella magrezza una soluzione per sentirsi in controllo di se stessa e accettata dagli altri, farà della magrezza una vera e propria dipendenza.
Ma dove finiscono le emozioni dell’adolescente?
Vergogna, tristezza, rabbia, paura del giudizio, del rifiuto, di non valere abbastanza, di non essere amati, la solitudine, …tutto finisce in un piatto, che viene sistematicamente rifiutato e rispedito al mittente: negare le emozioni, la fatica, i problemi quotidiani e la realtà diventa una soluzione efficace che spegne le emozioni negative, finché queste non vengono completamente sommerse e dimenticate. Alessitimia.
L’impossibilità di dare un nome alle emozioni è uno dei sintomi più difficili e resistenti dei disturbi del comportamento alimentare, in cui le persone faticano a descrivere, riconoscere e sentire le emozioni connesse alle esperienze che vivono, pur mantenendo un’assoluta capacità di analizzare in dettaglio i pensieri, i comportamenti e talora le sensazioni fisiche che le hanno accompagnate.
In questa distanza tra razionalità estrema e azione pura, si collocano le emozioni, spesso negate e mal giudicate, fino al punto di essere considerate semplicemente un intralcio, un segnale inutile di debolezza, anziché il segnale di una sofferenza che meriterebbe di essere ascoltata e accolta.
Il cibo allora offre una soluzione immediata: la restrizione, il digiuno, il vomito, l’abbuffata diventano modi disfunzionali che permettono però di sentirsi “sotto controllo”, o meglio, “in controllo di se stessi e delle proprie emozioni”, più sicuri della propria immagine, più padroni della propria vita. Cosa succederebbe se lasciassimo andare un po’ di controllo?
Questo scenario semplicemente non viene più esplorato e un circolo vizioso, disfunzionale ma rassicurante, prende il posto delle emozioni che non si riescono più neppure a nominare.
Nel libro viene descritta con grande delicatezza l’importanza di recuperare gradualmente questa esplorazione e la vitalità che porta con sé l’iniziare a sentire di nuovo. Briciole di emozioni positive possono aiutare lentamente ad affrontare briciole di emozioni che fanno più paura, per trovare insieme un modo più efficace di affrontarle.
Nutrire la resilienza e stimolare un senso di sé più forte e capace di affrontare le difficoltà è la grande sfida, iniziare a coltivare il dubbio che le emozioni non siano proprio così inutili e pericolose è il primo passo verso la guarigione.
“Briciole. Storie di un’anoressia”, di Alessandra Arachi (1994) Fetrinelli.










