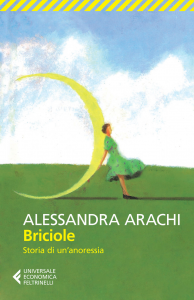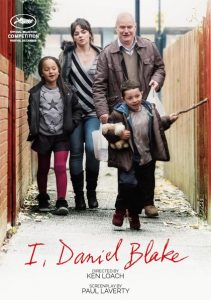In questi giorni di vacanza e tempo libero, in molti avranno vissuto un altro – e meno gradito – grande classico del Natale: l’influenza stagionale! Tra febbre, tosse e nervosismo da ferie perse, saranno in tanti ad essere caduti tra le braccia rassicuranti e sempre disponibili di una lunga serie tv.
 Per chi fosse finito nella rete del “Binge Watching” – senza entrare nel merito delle sue versioni più patologiche! – tra le ultime uscite prenatalizie non avrà certamente perso l’ultima stagione dei Peaky Blinders, serie tv britannica scritta e ideata da Steven Knight nel 2013, e le sfide del suo fascinoso protagonista: Thomas “Tommy” Shelby (Cillian Murphy). I fratelli Shelby – ‘in arte’ Peaky Blinders – sono una gang di Birmingham e vivono nella zona povera della città, Small Heath, loro quartier generale da quando gli antenati gitani hanno scelto di insediarsi in città e mettere su attività illegali. La storia inizia nel 1919, quando tutti i fratelli rientrano dalla Francia, dove hanno combattuto la prima guerra mondiale, e riprendono possesso dell’ “azienda di famiglia” affidata negli ultimi anni alle sorelle rimaste ad aspettarli.
Per chi fosse finito nella rete del “Binge Watching” – senza entrare nel merito delle sue versioni più patologiche! – tra le ultime uscite prenatalizie non avrà certamente perso l’ultima stagione dei Peaky Blinders, serie tv britannica scritta e ideata da Steven Knight nel 2013, e le sfide del suo fascinoso protagonista: Thomas “Tommy” Shelby (Cillian Murphy). I fratelli Shelby – ‘in arte’ Peaky Blinders – sono una gang di Birmingham e vivono nella zona povera della città, Small Heath, loro quartier generale da quando gli antenati gitani hanno scelto di insediarsi in città e mettere su attività illegali. La storia inizia nel 1919, quando tutti i fratelli rientrano dalla Francia, dove hanno combattuto la prima guerra mondiale, e riprendono possesso dell’ “azienda di famiglia” affidata negli ultimi anni alle sorelle rimaste ad aspettarli.
Ma cosa trovano al loro rientro? Il nemico combattuto in Francia, li aspettava tra le mura di casa. Una volta tornati liberi e padroni della città infatti, tutti i fratelli iniziano a sviluppare comportamenti bizzarri e imprevedibili: scatti d’ira, reazioni emotive incontrollate, abuso di sostanze e una eccessiva ricerca di rischi e efferatezze.
Come ormai in molte serie tv, il Disturbo da Stress Post-Traumatico diventa il “lato oscuro” di questi antieroi, il motore del loro agire e della narrazione stessa. Ma vediamoli più da vicino.
Tutti i sintomi del Disturbo da Stress Post-Traumatico (o nevrosi da guerra) sono ormai noti e riconoscibili anche per il grande pubblico: flashback, insonnia, incubi, allucinazioni, esplosioni di rabbia, depressione, abuso di sostanze. I fratelli Shelby reduci dalla guerra mostrano segnali evidenti di questa grave sofferenza psicologica che, aldilà della fiction cinematografica, può essere molto invalidante ed esporre al rischio di suicidio. Arthur e John sono aggressivi, irritabili, abusano di whiskey e cocaina, provano eccitamento nel minacciare, uccidere, sottomettere. Spesso perdono di vista gli affari o peggiorano in modo drammatico il loro comportamento di gangster, perdendo anche la stima e la fiducia della famiglia. Tommy Shelby invece appare diverso. La guerra non sembra aver intaccato la sua capacità di pianificare, di “proteggere” gli interessi di famiglia e di sedurre amici e nemici di ogni genere. E’ sempre in controllo delle sue emozioni e di quelle degli altri. Riesce a superare nuovi lutti e incidenti, nuove morti e abbandoni. E’ sempre vigile e capace di cogliere pericoli prima degli altri, restando calmo e capace di offrire sempre un piano B, per tutti.
Cosa permette a Tommy Shelby di restare così lucido, distaccato e impermeabile alla paura? Resilienza? Intelligenza? Narcisismo? Dissociazione?
Certamente una buona dose di Narcisismo sembra sostenerlo nei momenti di difficoltà e garantirgli un buon livello di energia psichica per andare avanti, inseguendo il sogno di abbandonare la malavita e scalare i vertici della politica del suo paese. Tuttavia questa autostima iperbolica non funziona affatto quando il trauma della guerra riemerge fuori dal suo controllo e proprio nei momenti di calma e serenità: il Narcisismo fallisce di fronte alla violenza dei sintomi da stress post traumatico e non lo aiuta a tenere insieme le parti diverse della sua identità, pre e post-traumatica. Quando è al sicuro Thomas Shelby diventa infatti improvvisamente vulnerabile: si trasforma, arrivano flashback, allucinazioni, paranoia, paura e una grave frammentazione del sé che ci mostrano tutta la gravità della Dissociazione traumatica interna di cui soffre. Abbiamo dunque due Tommy, uno “debole ed emotivo” che conserva sotto traccia i ricordi traumatici e il dolore della guerra, l’altro “forte e visibile agli altri” che è sempre pronto alla prossima battaglia. Quest’ultimo in effetti ha bisogno di una sfida per esistere, altrimenti le emozioni dell’altro prendono troppo spazio e forza nella sua mente. Questa alternanza rende la narrazione molto avvincente, ma allo stesso tempo ci permette di rintracciare sul piano clinico la presenza di sintomi post-traumatici solitamente meno evidenti, ma molto più frequenti nella realtà clinica delle persone che hanno vissuto una o più situazioni traumatiche, anche quando la loro parte più soffrente è offline. Ecco i sintomi post-traumatici che la parte “forte” di Tommy Shelby lascia trasparire:
- Il pervasivo distacco emotivo in situazioni emotive o di pericolo estreme, è primo e più importante segnale dissociativo. Salta la percezione del rischio e del pericolo di vita.
- Evitamento di situazioni o di argomenti legati al trauma, attraverso la manipolazione del contesto e delle persone. L’obiettivo implicito e non riesporsi alla situazione temuta.
- Ritiro dalle relazioni, Pervasivo senso di sfiducia nell’essere aiutati, Autonomia ed autosufficienza estreme anche di fronte a gravi difficoltà.
- Umore negativo e pensieri negativi persistenti su sé, sugli altri e sul proprio futuro
- Perdita di senso del sé e di obiettivi di vita prima importanti.
- Bisogno di sedare l’ansia attraverso l’uso di sostanze.
- Ricerca compulsiva del sesso per regolare emozioni sgradevoli e intollerabili.
- Il bisogno eccessivo di controllo su ogni aspetto della vita personale e familiare.
- Senso pervasivo di colpa e vergogna, anziché una sana e forse più tollerabile responsabilità.
 Le fiction ci offrono spesso uno spaccato della psicopatologia con la superficialità e la leggerezza che il contesto richiede, ma possono tuttavia offrire una rappresentazione chiara – seppur cinematografica – che permette importanti riflessioni cliniche.
Le fiction ci offrono spesso uno spaccato della psicopatologia con la superficialità e la leggerezza che il contesto richiede, ma possono tuttavia offrire una rappresentazione chiara – seppur cinematografica – che permette importanti riflessioni cliniche.
Un primo spunto clinico è legato proprio alle caratteristiche esteriori di Thomas Shelby e ci ricorda l’importanza, nella clinica quotidiana, di indagare e riconoscere sempre anche i sintomi più nascosti del Disturbo da Stress Post-Traumatico e non subire la “fascinazione” di alcune identità, o parti della personalità, narcisistiche, iper-razionalizzanti o evitanti, che tendono a mettere una maschera apparentemente normale, alle emozioni più intollerabili e dolorose legate al trauma. Questa maschera permette da un lato di “ri-organizzare” il proprio mondo interno così frammentato, ma ostacola dall’altro la comprensione della sofferenza emotiva, innalzando difese forti contro ogni intervento clinico. Quando assistiamo a questo tipo di sintomi nascosti, gli episodi più importanti da esplorare con i pazienti non sono solo quelli legati ai comportamenti distruttivi, di dipendenza o di rischio, ma soprattutto i momenti di noia e di vuoto, le giornate più calme e prive di impegni, le ore di solitudine. Solo da questa finestra è possibile intravedere la frammentazione interna e iniziare a prendersene cura.
Un secondo spunto clinico, che emerge chiaramente nella narrazione, è inoltre l’importanza nell’osservare nei pazienti la ciclicità dei sintomi a l’alternanza di periodi di calma a periodi di malessere. Quello che risulta nella fiction un facile espediente narrativo, diventa nella vita reale dei pazienti una “gabbia” in cui tendono a ripetersi ciclicamente emozioni, pensieri e comportamenti sempre uguali e difficili da evitare. La sensazione di non avere il controllo sulle proprie azioni, salvo poi recuperarlo attraverso strategie disfunzionali o dannose, è il ciclo da individuare e interrompere in terapia, osservando le emozioni che lo muovono e lo rendono necessario.
Con un appropriato intervento clinico Thomas Shelby non avrebbe probabilmente più avventure da raccontare, ma nella realtà clinica senza un appropriato intervento clinico il Disturbo da Stress Post-Traumatico tende a peggiorare nel tempo e ripresentarsi anche a distanza di molti anni nello stesso identico modo. Tendono inoltre a peggiorare anche l’umore e l’ideazione suicidaria esponendo la persona e i suoi familiari a rischi gravi per la salute.
Dunque lunga vita a Thomas Shelby! Ma resta importante nella vita reale cercare invece una risoluzione e darsi la possibilità di elaborare i traumi del passato, affinché non condizionino così intensamente il nostro presente e la nostra personalità.